Articolo uscito su l’Unita il 19 marzo 2024 in occasione dell’uscita del libro “Lo spettacolo del male” (Ponte alle Grazie, marzo 2024) e del festival Popsophia 2024 dedicato a questo tema – L’uomo è un animale malvagio. La riflessione sul male è potenzialmente sconfinata – male corporeo, il male psichico, il male metafisico, il male da un punto di vista biologico o da un punto di vista morale. Per circoscrivere il campo potremmo usare la formula utilizzata da Eric Fromm in un suo famoso saggio del 1973: il male come “distruttività umana”.
Non il male come semplice “aggressività adattiva” che l’uomo condivide con le altre specie animali, quell’innato istinto a difendersi, ad attaccare o fuggire quando ci si sente minacciati. D’altronde, sembra banale specificarlo, in natura non esiste il male e non esiste il bene: solo gli esseri umani proiettano queste categorie di valore sul mondo.
La distruttività, invece, è una caratteristica propriamente e unicamente umana. È la nostra tendenza maligna (da malus che in latino vuol dire ‘cattivo’ con un’accezione morale), la nostra propensione – con gradi diversi di consapevolezza – a compiere il male.
La distruttività umana, dunque, sconfina nel sadismo, nella crudeltà, nella tortura, nel crimine: non ha uno scopo biologico, è puramente distruttiva ed è connessa al piacere. Sigmund Freud ne Il disagio della civiltà l’aveva definita la “tendenza innata dell’uomo al male, all’aggressione, alla distruzione e perciò anche alla crudeltà” che è sempre pronta a manifestarsi quando cadono le inibizioni e le censure.
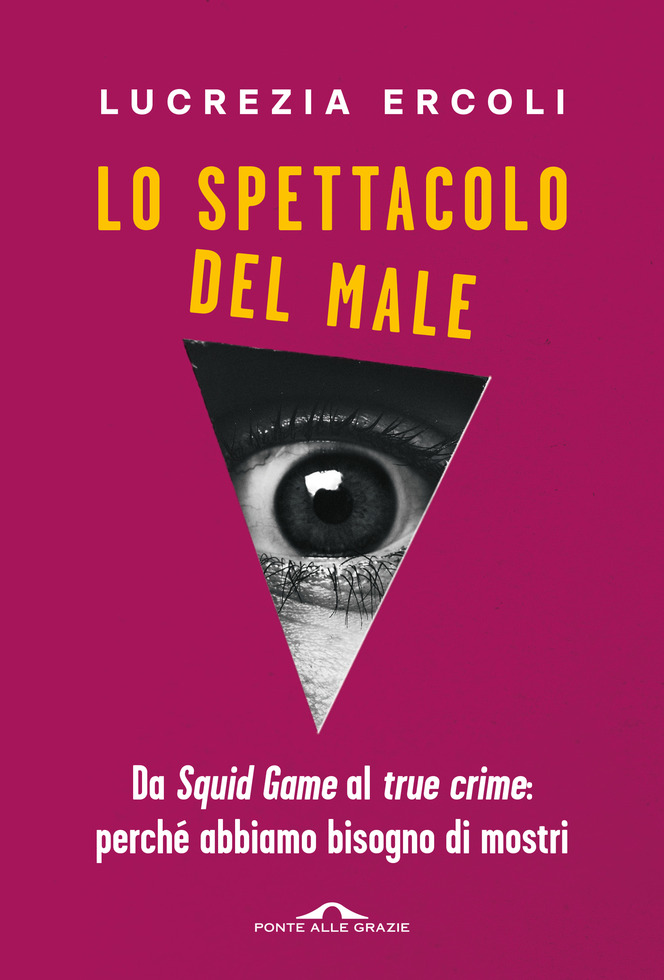
Se è vero che la violenza regna nell’universo animale, solo la crudeltà umana si annuncia come volontà di causare deliberatamente sofferenza. E questo male propriamente umano non è una caratteristica che si trova solo in alcuni individui ‘cattivi’: ‘fare il male’ è una questione che ci riguarda tutti in quanto esseri umani.
Abbiamo volutamente rimosso e occultato questa pulsione inconfessabile che non risparmia nessuno. Ma abbiamo sottovalutato le pericolose conseguenze di questa estromissione: il rimosso ritorna, in modo incontrollato ed imprevisto. Il male non è stato sconfitto dalla civiltà e dalla tecnica, anzi la tecnologia e il progresso hanno solo modificano – e, se possibile, aumentato – le possibilità di diffusione della nostra distruttività.
Siamo come intorpiditi da un’anestesia che ci ha fatto immaginare un mondo in cui fosse possibile cancellare il male, eliminare il conflitto, finirla per sempre con la crudeltà umana. Ma la strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni: con la celebrazione dei buoni sentimenti e con la retorica dei buoni propositi, siamo diventati incapaci di processare le nostre pulsioni e di conoscere la nostra parte maledetta, la nostra zona d’ombra.
Questa rimozione di una parte della nostra più intima natura, però, non ci impedisce di essere irresistibilmente attratti dallo “spettacolo del male”, dalla messa in scena della crudeltà (e del dolore) degli altri. Non a caso la parola ‘spettacolo’ deriva dal verbo latino spectare, cioè ‘guardare’: lo spettacolo macabro attrae il nostro sguardo, alimenta un piacere del vedere, produce un godimento visivo.
Siamo dei compulsivi consumatori di malvagità, in una danza macabra che unisce violenza e sguardo, e dobbiamo fare i conti con questo macabro voyeurismo. Ci vergogniamo ad ammetterlo, ma c’è un magnetismo visivo che rende affascinante proprio quello che, in base ai nostri condivisi codici estetici ed etici, dovremmo trovare ripugnante e terribile.
Siamo disgustati al solo pensiero dello spettacolo messo in scena nelle arene gladiatorie romane, ma siamo indifferenti rispetto alle efferate crudeltà della nostra epoca, allo spettacolo della morte che va in scena ogni giorno sui nostri smartphone.
Ci lasciamo bombardare dalle immagini crudeli – cullandoci nello sdegno morale o nella compassione – ma non vediamo più lo spettacolo nel suo complesso. Il sociologo Alessandro del Lago giustamente paragonava la copertura mediale delle guerre contemporanee al peep show, lo spettacolo erotico pensato per essere fruito in diretta da uno spettatore dietro una cabina di vetro. Una messa in scena che non solo prevede la presenza di uno spettatore che assiste, ma che addirittura non può farne a meno.
Non si tratta semplicemente di costruire una narrazione per un determinato target che ne fruisce a posteriori attraverso i media, ma di un peep show in presa diretta che non avrebbe luogo in assenza del pubblico esterno. E proprio come chi assiste a una performance sessuale da dietro un vetro, lo spettatore ne gode ma non se ne sente responsabile.
Ma il vetro che ci separa dallo spettacolo della crudeltà è stato infranto. Con il touch screen il nostro rapporto con le immagini non riguarda più solo il senso della vista: possiamo toccarle, ingrandirle, modificarle a nostro piacimento. Ne facciamo un’esperienza sempre più fisica e carnale.
E con lo sviluppo degli ambienti virtuali, non siamo ‘davanti’ al dolore degli altri, ma ‘dentro’: il meccanismo dell’empatia e dell’immedesimazione è sempre più manipolabile perché la distanza tra realtà e rappresentazione è azzerata.
Quando ci troviamo “dentro al dolore degli altri” – condizione che sperimentiamo quotidianamente più volte al giorno – non possiamo, e non dobbiamo, fare appello alla pura e semplice empatia.
Ci illudiamo di essere in prima linea aderendo all’emotività di uno spettacolo in diretta, ma rimaniamo tele-spettatori, spettatori a distanza. Il nostro sentimentalismo non è altro che una commozione ipocrita che dissimula la soddisfazione di saperci al sicuro mentre l’altro sta soffrendo.
Oggi più che mai risuona il monito di Susan Sontag: “Potremmo sentirci obbligati a guardare fotografie che documentano grandi crimini e crudeltà, ma dovremmo sentirci altrettanto obbligati a riflettere su quel che significa guardarle.”

